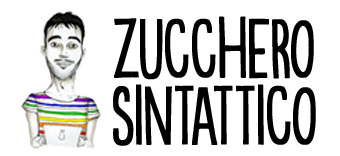Ho un’amica che non credeva nell’amore
/18 Commenti/in Me in bianco e nero/da Alessandro BianchiYellow
/26 Commenti/in Me in bianco e nero/da Alessandro BianchiLook how they shine for you
And everything you do
Yeah they were all yellow
Ops
/19 Commenti/in Me in bianco e nero/da Alessandro Bianchi“Il suo esercizio non è sbagliato. È peggio che sbagliato”
“Vede, ci sono esercizi che sono sbagliati in una maniera più o meno grave. Questo è un malato terminale. Invece il suo è proprio deceduto”
“Se all’esame mi dice una cosa così la butto fuori senza sentire altro”
“Ma cosa significa?! Ha fatto una frase che non vuol dire nulla, lo dica in italiano”
“No, no, no. Non c’entra niente, è tutto sbagliato”
17.5.2012
/14 Commenti/in Me in bianco e nero, Roba LGBT/da Alessandro BianchiÈ solo un finale
/15 Commenti/in Me in bianco e nero/da Alessandro BianchiHo scritto che sono una persona tendenzialmente malinconica. Pur avendo accettato questo mio essere, devo ammettere che mi ha procurato non poche difficoltà nel compilare il quadernino. Per una persona abituata a notare quell’unica nuvola grigia nel cielo sereno, scrivere una cosa bella ogni giorno non è semplice, ve lo garantisco. E all’inizio ero veramente in difficoltà. Mi sono ritrovato a scrivere sul quaderno cose come: “lo yogurt all’ananas, ehm, fantastico“. O anche: “i boxer dell’H&M non sono ancora scoloriti, evviva“. Mi faccio quasi pena. Tuttavia, a poco a poco ho iniziato a scorgere anche un po’ di cielo. Apprezzavo le piccole cose, ero felice per i successi dei miei amici, ero sereno. Ero… pronto.
Ventisei adesso sta di nuovo male. Accetta a fatica la parola F I N E, e non trova le forze di aprire una nuova pagina e cominciare a scrivere I N I Z I O, un po’ perché non ci sono parole con cui iniziare, e un po’ perché il capitolo precedente era davvero meraviglioso. Lo so, questa metafora del libro della vita e delle pagine e di tutto il resto è un po’ inflazionata e sarebbe il caso di darci un taglio, ma non me ne venivano altre. Mica mi pagano per scrivere sul blog. Resta il fatto che Ventisei è scoraggiato. Un nuovo capitolo, un altro ancora? Si chiede chi glielo faccia fare. Si chiede il motivo, visto che prima o poi finirà, di nuovo, e lui starà male. Di nuovo.
È per questo che scrivo questo post. Per dire delle cose a Ventisei. Per dirgli che deve stare tranquillo, che può prendersi tutto il tempo che vuole prima di ricominciare. Che non c’è nessuna fretta. Che sì, serve un po’ di fortuna, checché ti dicano i tuoi amici, ma prima o poi la ruota gira. Che ancora una volta devi essere forte, e essere coraggioso, perché credimi, Ventisei: in pochi sono coraggiosi quanto te. Ed è lo stesso se ora ti viene solo da piangere, perché piangere non è un reato, e non è nemmeno una cosa di cui vergognarsi. In un laboratorio di pc dell’università ci sono io, e sto piangendo per te. Io credo in te, Ventisei. E ti dico, ti grido, che puoi contare su di me. Non sei solo: ci sono io. Questo finale non è il vero finale. È solo UN finale. Perché se vado a riprendere quel quadernino, all’ultima pagina trovo scritto:
Ed è questo il finale che avrà anche il tuo libro. Lo so, che sarà così. Basta solo che non ti dimentichi che non sei solo. Ci sono io, ci sarò sempre. Attenderemo quel finale insieme.
Un’altra volta.
L’emicrania domenicale
/12 Commenti/in Cose che mi succedono, Me in bianco e nero/da Alessandro Bianchi
Tredici settimane di felicità
/14 Commenti/in Me in bianco e nero/da Alessandro Bianchi