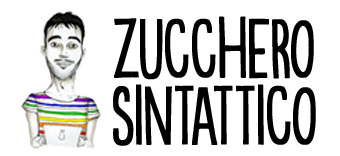Da questa parte del sipario
/31 Commenti/in Me in bianco e nero/da Alessandro BianchiSipario (cinque minuti di nero)
/14 Commenti/in Me in bianco e nero/da Alessandro BianchiAnche da adolescente piangevo, ma avevo paura a farlo in pubblico. Io, ragazzino influenzabile succube di tutte quelle norme sociali che se non seguivi ti portavano ad essere emarginato, norme come Non piangere, alzavo la musica e mi chiudevo in camera, rannicchiandomi sul letto con le ginocchia vicine al mento, e i palmi delle mani sugli occhi, per cinque minuti di nero. Cinque minuti di nero, e poi cinque minuti in cui strusciavo le mani sul piumone per assorbire le lacrime che lo avevano bagnato.
Poi, sapete, si cresce, si impara a sfogarsi in altre maniere. Ognuno ha le sue, e per esempio, che ne so, uno può scoprire che gli piace tanto scrivere, e che scrivendo gli riesce abbastanza bene dire quello che a voce proprio non gli viene. Quanti complessi, anche per questo. Ma perché non ho capito subito che dovevo fregarmene di quello che è normale fare? Normale. Il fatto è che mi veniva detto che io delle cose dovevo parlare, parlare a quattr’occhi, che le altre forme di comunicazione erano strambe.
Così ho imparato a parlare. Magari all’inizio posso apparire un po’ distaccato, o riservato, o timido, o remissivo, o introverso a livelli patologici, ma poi mi sciolgo e sostengo conversazioni anche brillanti. Il teatro, signori, è la migliore medicina per la società. La migliore lezione di psicologia è contenuta in un copione. La drammaturgia è la più intelligente concentrazione di studi sull’umanità. E così ho imparato a parlare, e così ho imparato a stare nel mondo, insegnamento che tutto sommato non me la sento di rinnegare.
Qualche volta, poi, succede che torno adolescente e mi butto sul letto e mi rinchiudo nei miei cinque minuti di nero.
Niente. Non ci sarà una morale per questa cosa che ho scritto. Non ci sarà un lieto fine, o un risvolto comico, o una conclusione che dia un senso. Non richiederò opinioni, o consigli, o lezioni di vita, perché a sbagliare sono bravo anche da me. Solo, mi andava di sfruttare uno dei mezzi di comunicazione del nuovo millennio per condividere dei pensieri, forse qualche richiesta, certamente un flusso di coscienza abilmente mascherato dall’allineamento giustificato di questo testo, e mi andava di farlo con lo strumento espressivo che preferisco.
Non fate leggere questa cosa alla mia mamma
/26 Commenti/in Me in bianco e nero/da Alessandro BianchiLa vigilia dell’autunno
/12 Commenti/in Me in bianco e nero/da Alessandro BianchiAspettare
/24 Commenti/in Me in bianco e nero/da Alessandro BianchiSolo
/22 Commenti/in Me in bianco e nero/da Alessandro BianchiHa 38 anni, Bartleboom. Lui pensa che da qualche parte, nel mondo, incontrerà un giorno una donna che, da sempre, è la sua donna. Ogni tanto si rammarica che il destino si ostini a farlo attendere con tanta indelicata tenacia, ma col tempo ha imparato a considerare la cosa con grande serenità. Quasi ogni giorno, ormai da anni, prende la penna in mano e le scrive. Non ha nomi e non ha indirizzi da mettere sulle buste: ma ha una vita da raccontare. E a chi, se non a lei? Lui pensa che quando si incontreranno sarà bello posarle sul grembo una scatola di mogano piena di lettere e dirle– Ti aspettavo.
Lei aprirà la scatola e lentamente, quando vorrà, leggerà le lettere una ad una e risalendo un chilometrico filo di inchiostro blu si prenderà gli anni – i giorni, gli istanti – che quell’uomo, prima ancora di conoscerla, già le aveva regalato. O forse, più semplicemente, capovolgerà la scatola e attonita davanti a quella buffa nevicata di lettere sorriderà dicendo a quell’uomo
– Tu sei matto.
E per sempre lo amerà.
Un mio amico parte per la Svezia
/18 Commenti/in Me in bianco e nero/da Alessandro BianchiTennis
/16 Commenti/in Me in bianco e nero/da Alessandro BianchiQuando sei cresciuta giocando a tennis,
non ne puoi più fare meno.
– Anna Kurnikova –