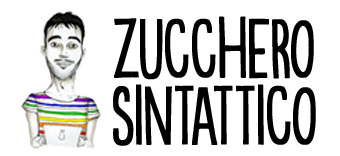Annuntio Vobis Gaudium Magnum: HABEMUS UBUNTU
Le macchine ce l’hanno con me. Si stanno ribellando. Stavo pensando che forse avrei dovuto prenderlo come un segno del destino, ma non credo al destino, per cui logicamente non posso nemmeno credere che il destino mi possa mandare dei segni. Dopo questa perla di stoltezza passo a raccontarvi dei recenti avvenimenti.
Dopo mesi e mesi di tentennamenti, giovedì pomeriggio mi decido ad installare Ubuntu [Breve parentesi: Ubuntu è un sistema operativo, tipo Windows]. Metto il disco, e non funziona. Riavvio il computer, e non funziona. Aggeggio nel BIOS, e non funziona. Perdo tutta – forse non avete letto bene, lo ripeto: TUTTA – la giornata a cercare di installare ‘sto cacchio di Ubuntu e non mi riesce.
E stanotte torno a casa, e trovo sul tavolo un messaggio di mio papà “Ubuntu funziona, il nome utente è ale e la password è quella che avevi detto te“. Mi vengono quasi le lacrime, che si trasformano in un pianto copioso quando accendo il computer e vedo che effettivamente mi chiede se voglio avviare Windows oppure Ubuntu.
Adesso è doveroso ringraziare tutti, quindi:
– Grazie ad Annalisa e Nicola che mi hanno fornito il disco di installazione. Poi alla fine ne ho dovuto utilizzare un altro che ho masterizzato da me, ma grazie lo stesso
– Grazie a Simona per avermi fatto parlare con Enzo
– Grazie, quindi, ad Enzo, che molto gentilmente ha cercato di spiegare ad uno sconosciuto completamente ignorante in materia che cosa fosse una macchina virtuale
– Grazie a Laura per aver preso gli appunti di Fisica mentre io cercavo mi deprimevo sul programmino di Algoritmica
– Grazie a Vezio per aver tentato di consolarmi: “Eh, i computer fanno così, tu segui tutte le istruzioni e non funzionano per qualche strano motivo”
– Grazie a Filippo, che ormai è il mio tecnico di fiducia, anche se stavolta non ha potuto fare niente contro la forza di ribellione delle macchine nei miei confronti
– Grazie a Giuli, per… boh, così!
– Grazie a Valentina, per avermi caldamente consigliato di cambiare computer. E’ sempre una soluzione…
– E infine, Grazie al Santo Padre, che non è il Papa, ma è il papà – mio papà – perché in casa lo chiamiamo per scherzo il Mago del Web, ma delle volte qualcosa ci capisce davvero (e poi ha avuto culo).
Ed ora c’è la seconda mission: impostare la rete internet!
Ragazziiiiii, mi date una mano?