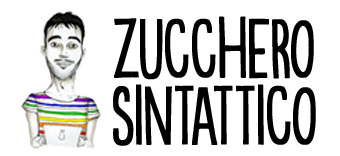[ Attenzione. Lo scritto che segue è terribilmente personale, e con molta probabilità potrà sembrarvi disgustoso, melenso e, soprattutto, patetico. Si tratta – ahimé – di un post in cui non mi curerò di esplicitare tutto, ma anzi potrei lasciare oscure molte parti (con la conseguente antipatia che scaturirà nei confronti della mia enigmaticità insopportabile). Sarà un post in cui non mi curerò di scrivere attraverso uno stile particolare; potrei farvi ribrezzo, o urtare la vostra sensibilità, oppure scatenare reazioni di masochistico piacere. Sfortunatamente, questo post è anche necessario affinché il peso che mi opprime in questi giorni venga liberato in maniera definitiva. Per questo motivo non posso in alcun modo esimermi dallo scrivere – ammettere / rivelare / dichiarare pubblicamente – ciò che segue; quello che mi è concesso fare per alleggerire un eventuale imbarazzo è scusarmi preventivamente, e ricordarvi che potete interrompere la lettura in qualsiasi momento. Grazie ]
Si dice che le parole, in questi casi, non servano. Non sono d’accordo. Il mio caso è proprio quello che ha bisogno di parole: parole di conclusione. Quelle parole che alla fine di un romanzo hanno la funzione di chiarire ogni dettaglio che al lettore potrebbe essere rimasto confuso; quelle parole liberatorie, che magari sono già state pronunciate nell’intimità, ma che vanno ribadite per forza e con forza, altrimenti si ha l’impressione che manchi qualcosa, che non si potrà mai essere completamente soddisfatti, che la situazione non è stata davvero superata. Parole da far poi seguire da un punto, fermo e indelebile, in grado di porre fine non solo al periodo, né solo al capoverso, ma a tutto il capitolo. Ed è solo con questa certezza – questo punto – che si può cominciare un capitolo nuovo, denso di fatti, e descrizioni, e dialoghi, e colpi di scena. Il classico e banale “voltare pagina”. Ricominciare. Rinascere. E sia benedetto colui che ha inventato la leggenda della fenice che dopo la morte riprende vita dalle proprie ceneri, perché è un’immagine vivida, calda, luminosa, che in qualche modo… mi aiuta.
Voglio fare un paragone, sebbene già mi renda conto che non riuscirò neanche lontanamente a riprodurre nemmeno un’ombra vaga della mia situazione attuale. Nemmeno una sfumatura confusa del mio dolore. Al liceo avevo problemi con una materia, in particolare: fisica. Avevo un professore molto bravo, ma che esigeva un livello elevato. Le insufficienze – svariati 2 e 3 e 5 – arrivavano una dopo l’altra. Ogni tanto un 6 a farmi respirare, ma mai nessuna soddisfazione che mi convincesse che avevo realmente superato il mio ostacolo. All’inizio mi scoraggiai. Mi sentivo impotente, mi sembrava impossibile riuscire. Poi, finalmente, per quanto fosse strano in quel periodo che io avessi una qualche reazione determinata, presi quella difficoltà come una sfida. E la affrontai.
In questi giorni ho dato il peggio di me. Di fronte alle persone che costituiscono il meglio di me. Persone che mi hanno visto piangere finché c’erano lacrime; persone che sono venute a casa mia, la mattina, per buttarmi giù dal letto. Persone che mi hanno preso e messo su un treno, per tentare di farmi svagare; e riempito di gelato, e ogni altro genere di coccole, e non sono rimaste deluse se gli dicevo che quel gelato lo percepivo amaro, amarissimo. Persone che sono rimaste ore al telefono a sentire solo singhiozzi; persone che mi reggevano mentre mi vomitavo addosso, e mi portavano il bicchiere d’acqua alla bocca intanto che mi dicevano di “non sbrodolare, però”; persone che, dopo quattro ore di treno, la prima cosa che hanno fatto è stata quella di abbracciarmi. E ancora persone che mi hanno letto, in quelle due uniche frasi che riuscivo a dire – Non riesco, non ce la faccio – e risposto, l’unica risposta sicura che si può dare in questi casi – Mi spiace, ma il tempo, vedrai… Persone che mi passavano un nuovo fazzoletto mentre altre lacrime mi sommergevano di moccio, e mentre il sangue mi usciva dal naso ormai leso dal troppo piangere. Persone che, conoscendomi ormai molto bene, si sono fatte da parte, in silenzio, non chiedendomi niente, o facendo finta di nulla, perché sapevano che da parte loro io avrei voluto così; persone che hanno cambiato i loro programmi, per me; persone che mi davano dei colpi in testa, o mi tiravano per la maglia, non appena notavano che la mia mente aveva preso a vagare altrove. Persone che erano desiderose di darmi una mano, e dicendomi “Ci sono” aspettavano soltanto che io la chiedessi. Persone che hanno sopportato il mio immenso, sconfinato, incommensurabile egocentrismo; e le mie ripetitive, pesanti e patetiche richieste d’aiuto, e le hanno soddisfatte, offrendomi tutto quello che potevano, perfino il loro tempo. Persone che mi hanno donato la loro fisicità: sotto forma di abbracci, o di baci, o di pacche sulle spalle o sulle ginocchia; che mi hanno stretto, preso le mani, guidato, detto parole di conforto, parole sentite. Persone che amo e che normalmente chiamo amici, ma che in questo periodo ho visto soltanto come persone, perché non ero capace – né fisicamente, né mentalmente – a vedere importanti.
E dentro? Annegare. Non finire mai di annegare. Piangere, dentro. Soffrire. Sentire un vuoto, un vuoto che in qualche modo riesce ad essere pesantissimo. Svegliarsi, e desiderare che quel soffitto cadesse, subito, e facesse finire tutto. Avere paura di andare a dormire, per timore del risveglio, per timore di dover affrontare ogni ricordo, di nuovo. Perdere l’equilibrio, dentro. Convincersi delle parole “mai” e “impossibile”. Questo, dentro. Tanto, tantissimo vuoto.
Brucia come un taglio nel sale
Quando lei lo baciò disse: Amore,
non farmi male, non farmi soffrire
Capire il significato delle canzoni che solitamente si cantano sovrappensiero, capirlo davvero, coglierne il senso, davvero. Forse è l’unica cosa positiva che ho acquisito da quello che mi è capitato. Ascoltare una canzone, sentirla tua, come se fosse stata scritta per te; o guardare una commedia che sei già andato a vedere altre due volte, e improvvisamente avvertire più emozioni, capirla sotto l’influsso di sfumature nuove. Essere consapevoli. Essere sensibili.
Portami con te
non voltarti
conducimi alla luce del giorno
Portami con te
non lasciarmi
io sono bendato ma sento già il calore
E’ il momento di svegliarmi
è tempo di rinascere
sento addosso le tue mani
ed è un caldo richiamo perché
ho bisogno di svegliarmi
di prendermi cura di te
ritorno alla vita
Me l’hanno detto tutti quelli che l’hanno provato. Il tempo. Il tempo che ha il potere di guarire tutte le ferite. Il tempo. Il tempo mi fa incazzare: illude tutti che possa guarire le ferite. Invece fa una cosa diversa, decisamente più subdola: fa abituare alle ferite. La routine mi assorbirà di nuovo, e pian piano mi abituerò, passivamente, al dolore. No, non sono più il tipo che aspetta. Qualche anno fa aspettavo – aspettavo Godot – ma adesso non più. Negli ultimi tempi ho imparato a rischiare, a provare, a sudare, a mettermi in gioco. E ovviamente sono caduto molte volte: sono state più le volte in cui ho fallito che quelle in cui sono riuscito. Ma quelle volte in cui ho vinto mi hanno ripagato di tutti gli sforzi.
E allora?
E allora sono caduto. Questa di adesso è la caduta più dolorosa di tutte. Ho contusioni dappertutto. Lividi mentali. Graffi che ho più volte implorato si concretizzassero, affinché potessi finalmente sfogarmi per qualcosa che non fosse solo un’idea o un’assenza. E allora devo reagire. Non posso essere sottomesso dal tempo, o da sentenze universali. “Non mi innamorerò mai più”. No. Lo penso, ma lo voglio davvero? No. IO AMO. E non mi vergogno a dirlo. IO AMO. Sono condannato ad affezionarmi alle persone, a voler loro bene, ad aver bisogno di loro, a non poter stare solo. IO AMO. E accetto di soffrire, di cadere, di perdere, di annientarmi.
IO AMO
Questo era il punto. Questa era la conclusione che volevo affermare. Incidere sulla pelle, farla sanguinare. Imprimerla nei meandri della ragione, là dove si raccolgono le convinzioni più profonde. Io amo, e questo è il valore su cui si fonda tutta la mia vita. L’ho ammesso a me stesso. E ora l’ho detto, l’ho scritto. E’ qui, è fermo, e indelebile: il punto. Ora posso reagire, ora posso voltare pagina.
E ricordo – ricordo proprio adesso – che, al liceo, finì più o meno così:
Ce la posso fare.