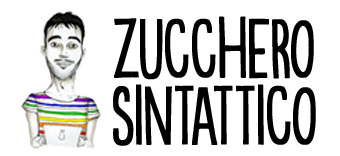Questo pezzo è stato pubblicato per la prima volta nella newsletter di Senza Rossetto, il progetto di Giulia Cuter e Giulia Perona che racconta le donne di ieri, di oggi e di domani. Potete ascoltare il podcast su Spotify, Spreaker o iTunes e potete iscrivervi alla newsletter qui. Ve lo consiglio caldamente!
L’illustrazione qui sopra è di Barbara Lupo.
_
Il protagonista di una delle ultime serie di cui mi sono innamorato è un liceale che deve confessare al suo migliore amico di essere gay. Lo fa mentre entrambi si stanno sfidando a Fifa, la scena dura appena sei minuti e si conclude con loro che sono ancora migliori amici e con me in lacrime sotto al piumone. La serie, forse qualcuno l’avrà riconosciuta, si intitola Skam, e sta facendo impazzire teenager (e non solo) di tutto il mondo, sia per il suo linguaggio così contemporaneo, sia per gli argomenti che affronta e il modo in cui li affronta, perfettamente in linea con una platea del 2019. Il coming out raccontato da Skam è semplice, rapido, naturale, e assomiglia a come mi immagino che siano molti dei coming out oggi. Non è sempre stato così.
Fino a pochi anni fa non esistevano molti personaggi omosessuali nelle serie tv, per non parlare dei protagonisti. A quel che mi risulta, la prima è stata Ellen Morgan nella sitcom Ellen, interpretata da Ellen DeGeneres. Nell’aprile del 1997 è andata in onda una doppia puntata intitolata The Puppy Episode, in cui la protagonista dichiarava a una ragazza di essere lesbica, dicendolo per errore al microfono di un aeroporto, e rivelandolo anche a una marea di sconosciuti. L’episodio è stato particolarmente significativo per una duplice ragione: intanto era una delle prime volte che un prodotto televisivo presentava un protagonista omosessuale, che peraltro dava il nome alla sitcom. Da lì a poco sarebbero state lanciate Queer as folk e Will and Grace, e più tardi The L Word, fino ad arrivare alle serie degli ultimi anni, come Transparent, Looking, Sense8, Pose, in cui la rappresentazione di personaggi LGBT+ è salita fino all’8,8% nel 2018. Ma da qualche parte si doveva pur iniziare, ed è stato appunto The Puppy Episode.
Quella puntata è passata alla storia perché, prima della sua messa in onda, il Time aveva pubblicato una copertina di Ellen DeGeneres che titolava “Yep, I’m Gay”. Non solo il personaggio era uscito fuori dall’armadio, ma anche l’attrice, e nello stesso momento. Il che ha avuto delle conseguenze: Ellen ha cominciato a ricevere lettere piene di insulti, diverse minacce di morte e innumerevoli editoriali schierati contro la sua decisione di fare coming out. Dopo un anno, la sitcom venne cancellata, molte persone persero il lavoro e lei stessa rimase disoccupata per alcuni anni prima che qualcuno le desse la possibilità di riprovare la tv come conduttrice di uno show (che è attualmente alla sua sedicesima stagione consecutiva e ha consacrato Ellen come una delle presentatrici più importanti della televisione statunitense).
Nel suo stand-up comedy visibile su Netflix, Relatable, Ellen dice che il periodo successivo al coming out è stato uno dei più difficili della sua vita, ma anche la parte migliore del viaggio: «Stavo celando una parte di me e ogni volta che nascondiamo qualcosa a qualcuno è perché ci preoccupa ciò che penseranno di noi. E anche se sarebbe stato difficile ero arrivata al punto in cui mi importava più sentirmi orgogliosa di me stessa e vivere nella verità piuttosto che preoccuparmi del giudizio altrui.»
Pochi minuti prima, afferma anche che, a meno di non essersi persi nel bosco, ognuno deve seguire il proprio percorso, non quello che gli indicano gli altri. È fondamentale: il coming out ha poco senso se è un agente esterno che ti obbliga a farlo o se qualcun altro lo rivela per te: questo gesto ha effettivamente un altro nome, si chiama outing, e non è piacevole per nessuno.
A parte, forse, per George Michael, che nel 1998 fu arrestato per atti osceni in luogo pubblico dopo aver esternato delle esplicite proposte sessuali a colui che non sapeva essere un poliziotto della buoncostume in borghese. La vicenda destò molto scandalo, ma il cantante ne approfittò per scrivere la sceneggiatura del video di Outside, che sarebbe uscito poco tempo dopo e ritraeva diverse coppie di persone fare sesso in luoghi pubblici prima di essere beccati dalla polizia. Da allora il leader degli Wham! diventò anche uno dei più fervidi sostenitori dei diritti LGBT+.
Quella di George Michael è ovviamente un’eccezione nella storia dei coming out forzati che sono andati a buon fine. L’idea alla base del rivelare agli altri una parte così profonda del proprio essere è che sia un gesto volontario. Il coming out è una di quelle cose che non si possono definire con un solo aggettivo. Se da una parte è spontaneo e non dovuto, dall’altra è politico e necessario.
Necessario: il coming out serve. Ancora oggi. Negli ultimi mesi hanno fatto discutere le parole di Mahmood, il vincitore di Sanremo 2019, che ha dichiarato a una testata nazionale che il coming out è un passo indietro, e più recentemente ha ribadito di come le etichette portino distanza tra le persone. Non so se Mahmood si sia espresso male o creda davvero nella completa inutilità del coming out (come suggeriscono alcune sue dichiarazioni). Io penso che nessuno, nemmeno l’artista più famoso del mondo, debba sentirsi in dovere di svelare la propria omosessualità. Certo, quantomeno dovrebbe interrogarsi sulle proprie responsabilità da personaggio pubblico, ma essere riconosciuto per strada non ti impone l’obbligo di mettere al corrente le persone di un aspetto della tua vita privata. Dopodiché, quando qualcuno sceglie di fare coming out, fa un immenso regalo al mondo.
I dati sull’omofobia in Italia parlano chiaro: l’ultimo aggiornamento di Arcigay (che nel momento in cui scrivo fa riferimento al 2018, ma a breve uscirà il nuovo report) segnalava 119 casi di omotransfobia, un numero al ribasso che si riferisce solo a quelli riportati dalla stampa, perché non tutte le vittime denunciano. In uno scenario del genere il coming out non può essere considerato un atto inutile.
C’è una notizia positiva, tuttavia, e a farla notare per primo è stato Sir Ian McKellen, l’attore britannico noto, per esempio, per aver interpretato Gandalf nella saga cinematografica del Signore degli Anelli (ma è stato anche uno dei due vecchietti protagonisti di Vicious, una esilarante sitcom che racconta le giornate di una coppia omosessuale insieme da cinquant’anni). McKellen ha fatto coming out nel 1988, a quarantanove anni, durante un programma radiofonico della BBC.
Nel trentesimo anniversario del suo coming out pubblico, l’attore ha dichiarato di aver festeggiato. In un tweet diventato virale, ha detto: «Non ho mai conosciuto nessun omosessuale che si sia pentito di aver fatto coming out. Me compreso». La semplicità di questo concetto è disarmante. È vero, ho incontrato anch’io centinaia di persone, tra gay, lesbiche, bisessuali e transgender, molte delle quali mi hanno confessato di aver nutrito forti dubbi e paure prima di dichiararsi, ma non ne conosco neanche una che non sia felice della scelta fatta. Includendo me stesso, ovviamente.
Ho fatto coming out con i miei amici nel 2009, ma ci ho messo un anno per decidere di dirlo anche alla mia famiglia. Sapevo che dopo non sarei più potuto tornare indietro, non si può dire “scherzavo” (o meglio, certo che si può, tutti possiamo fare errori di valutazione, ma se la rettifica serve solo per tornare a fingere di essere eterosessuali cisgender diventa inutile tutto lo sforzo raccolto per dichiararsi la prima volta). Le persone a cui chiedevo consiglio in quei giorni mi dicevano che, se davvero ero sereno con me stesso, dovevo andare avanti con la mia decisione di rivelarlo ai miei famigliari. “Tanto prima o poi dovrai farlo”, aggiungevano. Attenzione a quel “dovrai”: non è scritto da nessuna parte che fare coming out sia un obbligo da rispettare nel percorso di una persona omosessuale. Puoi passare benissimo un’esistenza dignitosa anche rimanendo chiuso nell’armadio. Quel “dovrai” significa soltanto che il coming out è una condizione necessaria per vivere alla luce del sole, nella verità. Esattamente come aveva detto Ellen DeGeneres, le cui parole ho sentito molto vicine.
Quando la giornalista del Corriere della Sera ha chiesto a Paola Egonu, campionessa della Nazionale italiana di pallavolo, come mai dicesse con tanta semplicità di avere una fidanzata, lei ha risposto: “Lo trovo normale”.
In effetti, adesso non ho più bisogno di fare coming out. Per usare la stessa espressione di Jonathan Van Ness, il favoloso parrucchiere di Queer Eye, “il cielo è blu, l’erba è verde”. Faccio parte di quella schiera di persone la cui omosessualità è abbastanza… evidente, diciamo. Senza dubbio non la nascondo, e questo mi evita un sacco di paranoie inutili. Sono tanti anni ormai che il mio orientamento sessuale non mi causa problemi di grave entità – a livello personale, intendo, perché i problemi esistono comunque nel momento in cui vivo in una società in cui le persone LGBT+ non hanno gli stessi diritti degli altri e ogni giorno rischiano la salute a causa dell’omofobia diffusa e non sufficientemente punita. Sono circondato da una famiglia che mi ama e tanti amici che mi sostengono. Negli ambienti universitari e lavorativi che ho frequentato non ho mai avuto difficoltà legate alla mia omosessualità. Sono fortunato, sono un privilegiato, non va sempre così.
Il coming out è una scommessa: da una parte, metti a rischio un aspetto di te, ti esponi in una società per cui tu rappresenti un’interferenza. D’altronde, fare coming out significa aggiungere diversità al mondo, fare in modo che tutti comincino a trovare “normale” un ambiente naturalmente pieno di differenze. Ma significa, prima di tutto, mettere le basi per costruire la propria felicità, vivere nella verità e sentirsi orgogliosi di sé stessi.